Kafka in valigia
(3 luglio 1883 ♦ 3 luglio 2021)
Tempo di lettura: 7 minuti
Il 3 luglio 1883, esattamente 138 anni fa, nasceva Franz Kafka, forse l’autore più grande, sicuramente l’autore più novecentesco del XX secolo.
L’estate rovente non sembra conciliare la lettura di un autore come Kafka che proprio a chi non ha mai osato sfogliare uno dei suoi libri sembra un macigno insostenibile e decisamente fuori stagione. Eppure è questo il macigno che ha il potere di alleggerire i pesi e le fatiche della vita poiché tra le pagine è possibile acquisire una consapevolezza rara in grado di farci prendere le distanze ma allo stesso tempo consapevolezza dei nostri limiti umani. Se la convinzione che le nostre esistenze acquistino consistenza grazie ai traguardi allora non ci si dimentichi che proprio i nostri successi non sono altro che il superamento delle nostre fragilità e dunque l’altra faccia della medaglia che si è tentati di nascondere.

La scrittura di Kafka si può considerare solo in perenne equilibrio precario, esattamente come la medaglia della vita si alimenta tra un fallimento e un successo. È risaputo che in vita Kafka non si considerasse nemmeno scrittore e se non fosse stato per l’amico Max Brod, oggi nessuno lo ricorderebbe come uno dei più grandi scrittori del secolo scorso. È certamente uno scrittore complesso per chi ha passato la vita a tentare di comprenderlo e interpretarlo ma è sorprendente come la potenza della sua scrittura lo renda semplice ai profani. D’altra parte non si potrà considerarla un’opera accessibile, ma non si tratta di competenza o conoscenza dell’autore; in realtà, più ci si addentra e più ci si allontana.

Certo è, che non è facile concepire l’idea di portare uno dei suoi libri in valigia. Eppure proprio così come la stanchezza attende impaziente un viaggio, così questa potrebbe rivelarsi un attivatore fondamentale per avvicinarsi a Kafka, come l’inizio di una vacanza crea le condizioni perfette per un nuovo amore. Proprio mentre le energie vengono meno, la stanchezza tenta di attivare la ricerca di riposo, e se da un lato si rivela vana perché generatrice a sua volta di stanchezza, dall’altro è proprio la mancanza di energie che mette in luce ciò che sfinisce. In particolare, in questo circolo vizioso si apre un vortice, (che la critica individua nel processo di rovesciamento tipicamente kafkiano), che svela almeno in parte uno degli aspetti più affascinanti che si cela nelle pagine esauste di Kafka e cioè il presupposto necessario che i romanzi debbano restare incompiuti di fronte a qualunque tentazione di metterci la parola “fine” perché farebbe svanire l’essenza stessa del romanzo.
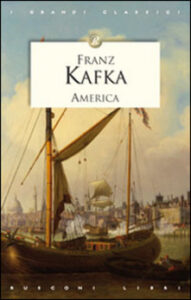 In Der Verschollene (Americana), [qui] Karl raggiunge il Nuovo Mondo provato da un viaggio estenuante che tuttavia non inaugura l’inizio del sogno americano, ma rimarca piuttosto la mancanza di una patria, quella di origine e soprattutto l’assenza di una nuova che in principio doveva accoglierlo dopo l’esilio dall’Europa.
In Der Verschollene (Americana), [qui] Karl raggiunge il Nuovo Mondo provato da un viaggio estenuante che tuttavia non inaugura l’inizio del sogno americano, ma rimarca piuttosto la mancanza di una patria, quella di origine e soprattutto l’assenza di una nuova che in principio doveva accoglierlo dopo l’esilio dall’Europa.
Al giovane Karl Roßmann non basterà mostrare umiltà e buona volontà all’Hotel Occidentale per intraprendere l’ascesa sociale; in Kafka questi non costituiscono i requisiti per il successo bensì i presupposti per il fallimento. Il lettore non può che partecipare passivamente alle sventure più che avventure del giovane perdente.
Chi non ha mai incontrato, almeno una volta, un Delamarche o un Robinson che da amici premurosi si rivelano presto i migliori opportunisti sulla piazza, pronti a tutto pur di nutrirsi dei pochi mezzi che l’ingenuo Karl tiene con parsimonia e fatica. Dopotutto il mondo ne è pieno. Tuttavia Karl persegue la sua battaglia per la sopravvivenza conservando l’unica cosa che possiede davvero; il suo buon cuore. Lo conserva sì, ma a caro un prezzo. Il tentativo di realizzare una nuova vita lo spinge lontano da qualsiasi relazione umana, mentre quello di uscire da situazioni critiche lo indebolisce al punto che ogni volta è costretto a ripartire per un altrove sconosciuto; e ancora un volta Karl deve ricominciare da capo. Poi l’occasione della vita è lì, su un manifesto piuttosto inverosimile a dir la verità, ma davanti ai suoi occhi stanchi e increduli, il disperato bisogno di appartenere a qualcosa lo trattiene e a convincerlo bastano poche parole che legge: “tutti sono i benvenuti”.
Se scrivere, per Kafka, significa denudarsi di fronte a se stessi, leggere diventa lo specchio senza il filtro della menzogna. È questa, probabilmente, la ragione che impedisce a Josef K. di iniziare la sua difesa in Der Prozess (Il Processo), o forse la ragione stessa. La necessità di prendere in mano la propria difesa è anche sintomo di sfiducia nei confronti di un Tribunale che intenta un processo su fragili e inconsistenti accuse, ma soprattutto costituisce il desiderio di misurarsi con il più terribile di tutti: il proprio sguardo giudicante. Josef K., brillante dirigente di banca, impeccabile e irreprensibile uomo di mondo tiene a bada l’intero ufficio ma gli basta oltrepassare la soglia di un lurido e insignificante ripostiglio per avere un crollo di nervi.
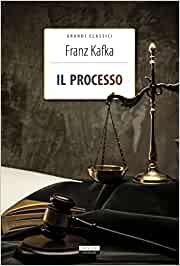 La lentezza con cui prosegue Der Prozess (Il Processo)[qui] è in netto contrasto con la durata degli eventi che si condensano in pochi attimi. Sembra durare un’infinità la sosta di Josef K. nelle soffitte ma, poco dopo il suo ingresso, la perdita progressiva di forze lo trascina velocemente all’uscita. Il tempo dilatato è palpabile anche nello studio di Titorelli; sembrano migliaia i quadri identici che l’artista mostra uno dopo l’altro al nostro Josef K., ma in questa minuscola stanza senza finestre da aprire e schiacciata dal basso soffitto, si può restare solo pochi minuti a causa dell’aria irrespirabile.
La lentezza con cui prosegue Der Prozess (Il Processo)[qui] è in netto contrasto con la durata degli eventi che si condensano in pochi attimi. Sembra durare un’infinità la sosta di Josef K. nelle soffitte ma, poco dopo il suo ingresso, la perdita progressiva di forze lo trascina velocemente all’uscita. Il tempo dilatato è palpabile anche nello studio di Titorelli; sembrano migliaia i quadri identici che l’artista mostra uno dopo l’altro al nostro Josef K., ma in questa minuscola stanza senza finestre da aprire e schiacciata dal basso soffitto, si può restare solo pochi minuti a causa dell’aria irrespirabile.
Se il procedimento si evolve inarrestabile questo non vale per l’autobiografia che Josef K. intende scrivere a sua difesa e resta bloccata dall’inizio proprio per la mancanza di energie che il processo stesso gli toglie. La frenesia di chiuderlo in realtà lo allontana da una risoluzione, salvo poi realizzare che non sembra esserci alcun Tribunale, alcun “vero” giudice e nemmeno una sentenza e ciò nonostante il verdetto sarà irrevocabile.
 E cosa fare quando un uomo qualsiasi che proviene da un posto qualsiasi riceve la chiamata dal Castello? Dove andare se al Castello non è consentito l’ingresso e al villaggio dove K. giunge non si può restare? Kafka, in Das Schloß (Il Castello), [qui] fornisce una dimensione narrativa priva di qualunque indicazione temporale o spaziale anche se il vero smarrimento della “storia” è affidato al vuoto dei dialoghi disseminati tra le pagine che non permettono una reale evoluzione. Ci si dovrà affidare allo sguardo di K. per procedere a passo lento nella lettura; solo così si potrà, a fatica, voltare pagina.
E cosa fare quando un uomo qualsiasi che proviene da un posto qualsiasi riceve la chiamata dal Castello? Dove andare se al Castello non è consentito l’ingresso e al villaggio dove K. giunge non si può restare? Kafka, in Das Schloß (Il Castello), [qui] fornisce una dimensione narrativa priva di qualunque indicazione temporale o spaziale anche se il vero smarrimento della “storia” è affidato al vuoto dei dialoghi disseminati tra le pagine che non permettono una reale evoluzione. Ci si dovrà affidare allo sguardo di K. per procedere a passo lento nella lettura; solo così si potrà, a fatica, voltare pagina.
Lo sguardo di K. è il perno attorno al quale ruotano gli sguardi sospettosi e morbosi delle figurine, più che personaggi, che popolano il romanzo; un continuo cambio di prospettiva che alla lunga indebolisce il lungo e faticoso cammino verso l’irraggiungibile Castello che non lo perde mai di vista. Il bisogno incessante di riposo ritarda o anticipa gli eventi e più ci si convince che la meta è vicina, più si realizza che K. non raggiungerà mai il suo obiettivo. Ma allora cosa spinge a continuare una lettura che sembra girare a vuoto, che sembra portare al nulla? Di fatto nulla, se non fosse che l’insistenza a voler riempire quel nulla ci costringe da un certo punto in poi a non poterne fare a meno.
“Da un certo punto in là non vi è più ritorno. Questo è il punto da raggiungere.” Che Kafka non me ne voglia se sono costretta a tirare in ballo uno degli aforismi scritti a Zürau! (Die Zürauer Aphorismen – Aforismi su Zürau).[qui]
Letture consigliate:
Beschreibung eines Kampfes – La descrizione di una battaglia (1904-1905)
Das Urteil – La Condanna e Die Verwandlung – La Metamorfosi (1912)
Ein Bericht für eine Akademie – Una relazione per un’accademia e Der Jäger Gracchus – Il Cacciatore Gracco (1917)
Der Bau – La Tana (1923-1924)








