Israele: il prezzo dell’orrore della guerra sionista per chi è costretto a farla
Tempo di lettura: 13 minuti
Israele: il prezzo dell’orrore della guerra sionista per chi è costretto a farla
In memoria dell’amico e collega Alberto Gigante.
Questo articolo è stato scritto attingendo ispirazioni e informazioni dal lascito del suo percorso umano e professionale a favore della Cultura della Pace e per il rispetto dei diritti umani.
“Cast Lead – colpirne cento per educarne uno”, documentario di Alberto Gigante, 2014. visibile qui
Il conflitto vietnamita fu la prima guerra della storia in cui il numero dei militari USA morti in combattimento fu superato dal numero degli ex combattenti morti per suicidio. Durante dieci anni di guerra morirono più di 58.000 soldati americani, più di 153.000 risultarono feriti e invalidi. Un numero compreso tra sessanta e centomila ex combattenti e veterani si tolsero la vita negli anni successivi.
Durante i primi cento giorni di guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza, l’esercito israeliano ha contato tra le proprie fila più morti e feriti che in 106 anni di presenza ebraica in Palestina. L’attacco militare in corso è una vera e propria guerra tra le più distruttive e letali del 21°secolo per entrambe le parti.
Quali ferite incurabili e quante tracce indelebili saranno inflitte sui corpi e nelle coscienze dei sopravvissuti?
“Flipping out”: ex combattenti fuori di testa
L’estremo crollo psicotico che può portare un combattente o un ex combattente alla follia e al suicidio, è provocato da una serie di disturbi da stress post-traumatico sempre più gravi che sfociano in quel particolare stato di alterazione di coscienza detto “flipping out”, da intendere come “uscire fuori di testa”.
“Flipping out” è il titolo di un documentario del regista israeliano Yoav Shamir che racconta come, dopo essere stati congedati con un bonus di 15.000 shekel (circa 4.300 dollari), ogni anno circa 20.000 neocongedate/i israeliani si recano in India: tra costoro, ogni anno, 2.000 ex soldati e soldatesse israeliane che vivono in India “flippano”, vanno fuori di testa.
Intere schiere di giovani israeliani poco più che ventenni concludono in condizioni psicologiche terribili il servizio militare e cercano lontano dal paese di ritrovare la propria identità e il proprio equilibrio interiore a contatto con la natura, adottando uno stile di vita semplice ed elementare, tentando di cancellare definitivamente la negatività delle proprie esperienze belliche. Scegliendo di passare lunghi periodi di permanenza all’estero, organizzandosi in vere e proprie piccole comunità o adottando scelte di tipo eremitico nelle montagne indiane e himalayane, in molti ce la fanno a cancellare il peso del loro insopportabile passato. Tanti altri, purtroppo, no, cadendo nel vortice della disperazione e delle tossicodipendenze.
Le scene introduttive del documentario mostrano soldati in assetto di guerra che irrompono nelle case palestinesi; quelle finali propongono le immagini di un gigantesco raduno rave in una spiaggia di Goa, con la partecipazione di diverse centinaia di ex soldati che fanno liberamente uso di ogni tipo di droghe e sostanze stupefacenti.
Le organizzazioni e le agenzie israeliane che si assumono la responsabilità dei problemi creati dal servizio militare, rispondono al crescente problema degli insediamenti in India attraverso centri di accoglienza per ex soldati coinvolti nel consumo di droga.
Warm House e Chabad Houses – luoghi comunitari fondati da ex ufficiali dell’esercito e da nuclei con finalità di ricerca, salvataggio e recupero di israeliani fuori di testa – riferiscono che il 90% di coloro che dopo il periodo di leva si recano in India, fa uso sistematico di droghe.
Un momento particolarmente significativo di “Flipping out” è la conclusione dell’incontro tra il vice primo ministro israeliano Eliyahu Yishai prima con una soldatessa (che, al suo secondo viaggio in India, gli dice: “qui ci si può sentire di nuovo normali. Niente bombardamenti, niente corruzione, niente pressione…”) e poi con un soldato (che spera di non ritornare in Israele e considera dannoso possedere un passaporto israeliano). Naturalmente Yishai enfatizza i meriti del governo (“questi ex soldati sono i nostri figli, i nostri ragazzi e ragazze…migliaia vengono qui e tornano a casa mentalmente devastati”), in una narrazione tesa a focalizzare l’attenzione sull’effetto, dimenticando la causa.
Gaza: la vetrina dell’industria bellica israeliana
Oltre a quella in corso, dal 2004 ad oggi, l’IDF, l’Esercito di Difesa Israeliano ha scatenato 9 operazioni militari contro la Striscia di Gaza, divenute tristemente note per l’uso indiscriminato di armi micidiali, per i crimini di guerra patiti dalla popolazione civile palestinese e per il significato assunto dall’escalation di episodi sempre più cruenti e letali. Ogni operazione è servita come banco di prova per le nuove tecnologie militari e come vetrina per promuoverne le vendite all’estero, garantendo enormi profitti all’industria bellica israeliana e trasformando la Striscia di Gaza, da prigione più grande del mondo, nel più grande poligono militare abitato su cui testare ogni tipo di arma e di armamento.
Le competenze maturate nel corso dei decenni e testate sul campo vengono oggi vendute agli alleati e ai partner di Israele in tutto il mondo, Italia inclusa, e includono: la sorveglianza delle frontiere; i sistemi di protezione perimetrale virtuale e fisica per i siti terrestri e marittimi; i sistemi di controllo per passeggeri, veicoli e merci negli aeroporti e nei porti; misure contro potenziali attacchi terroristici; disturbatori elettronici interferenti contro ordigni esplosivi e loro bonifica; protezione corazzata; soluzioni anti sommossa; armi non letali per le forze dell’ordine.
Gaza è diventata la vetrina dell’industria bellica israeliana: la condizione della Striscia in cui 2,4 milioni di Palestinesi sono forzatamente rinchiusi in una gabbia densamente popolata, ha offerto e continua ad offrire un laboratorio unico per la sperimentazione delle dottrine, delle tecnologie e delle nuove forme che un conflitto armato può assumere nel presente.
La più grande impennata di vendite belliche israeliane si è registrata sulla scia dell’operazione “Piombo Fuso”: l’uccisione di oltre 1.400 palestinesi e il bombardamento di infrastrutture civili e abitative, ha fatto registrare un record di vendite di ogni tipo di armamento impiegato che ha sfiorato il giro d’affari di sei miliardi di dollari. Ma anche al termine di ogni altro attacco, motivato da ragioni difensive e di sicurezza nazionale, sono state organizzate fiere internazionali per mettere in vendita la vasta gamma di prodotti testati “in battaglia” sulla popolazione civile di Gaza: missili, bombe, bombe al fosforo, bombe a grappolo, elicotteri, cacciabombardieri, droni, motovedette e veicoli corazzati robotizzati a controllo remoto senza equipaggio, scudi difensivi antiaerei, sistemi di puntamento satellitari, strumentazioni per visione notturna, sistemi di rilevazione termica, rilevatori di movimento, sensori radar.
L’operazione Piombo Fuso è iniziata il 27 dicembre 2008, è durata ventidue giorni.
Si è svolta in due fasi: una settimana di bombardamenti aerei, con cacciabombardieri F16, elicotteri AH 64 Apache e droni, anticipata da un attacco di sorpresa che ha colpito più di 100 obiettivi in meno di due ore, causando la morte di 225 e il ferimento di 700 palestinesi, seguita da due settimane di attacchi aerei e terrestri.
La missione di inchiesta del Consiglio per i diritti umani dell’ONU. capeggiata dal giudice ebreo sudafricano R. J .Goldstone e i dati forniti dall’UNRWA, Amnesty International, Human Rights Watch e da organizzazioni indipendenti sia israeliane che palestinesi, hanno accertato l’uccisione di 1385/1419 palestinesi, in maggioranza civili, inclusi 308 minori sotto i diciotto anni e di dieci militari e tre civili israeliani; il ferimento di 5.000 palestinesi e di 518 israeliani. Negli anni successivi, le altre operazioni, come “Pilastro di Difesa” nel 2012 o “Margine Protettivo” nel 2014, sono state tutte caratterizzate dalla proporzione diretta esistente tra la massima percentuale di morti e distruzioni e il massimo ricavato dalle vendite delle armi impiegate.
Sentry Tech, un sistema rivoluzionario per uccidere a distanza
La principale azienda di armamenti, la Rafael, leader mondiale nella vendita di droni militari, propone il catalogo più ampio e più aggiornato delle armi a controllo remoto: il Guardium è una macchina robot blindata che raggiunge la velocità di 80Km orari e che può sparare sui bersagli in movimento; il Protector è una motovedetta senza pilota; il drone Heron TP può trasportare oltre una tonnellata di materiale bellico; il Sentry Tech è un sistema che consente di sparare a distanza, senza correre nessun rischio, su chiunque sia sospettato di essere un terrorista, tramite l’applicazione del concetto “spot and shoot” che consente di manovrare, puntare e azionare armi da fuoco automatizzate, dopo l’identificazione del bersaglio per mezzo di telecamere di sorveglianza.
Secondo quanto è emerso dai media israeliani e dalle denunce internazionali, quest’ultima innovazione tecnologica definita “rivoluzionaria”, messa in funzione a difesa del Muro contro attacchi terroristici, ha provocato la morte di decine di palestinesi e il ferimento di un’attivista maltese; la Ong Dci Defense for Children Inernational ha riferito, tra gennaio 2009 e agosto 2010, l’uccisione accertata di 22 civili palestinesi e il ferimento di 14, per essere entrati in contatto con il Sentry Tech nella zona cuscinetto a ridosso del muro.
Secondo le autorità militari questi sistemi potranno permettere di combattere e uccidere in zone di guerra senza mettere a rischio i soldati; ma ciò che ha sollevato reazioni è stato il fatto che, in fase di sperimentazione, gli unici membri dell’esercito ad aver avuto accesso alle consolle delle sedi operative poste in luoghi lontani e sicuri all’interno di basi militari, sono state soldatesse dai 18 ai 20 anni, sedute a controllare sullo schermo la linea di demarcazione israelo-palestinese manovrando i joystick di comando dei fucili e pronte a cliccare, se autorizzate da un superiore collegato in chat.
Secondo Philip Alston, relatore speciale dell’ONU per le esecuzioni extragiudiziarie, “il pericolo è l’avanzata di una mentalità assassina in stile playstation che attribuirà alla guerra un carattere ludico e impersonale, lasciando la responsabilità materiale di vita o di morte a soldatesse poco più che maggiorenni senza un processo che appuri la presunta colpevolezza del “bersaglio”.
Un computer, una tastiera e un joystick, ecco i nuovi strumenti di morte utilizzati a scopo difensivo da personale femminile. Questo è quanto si percepisce dalle parole di Ben Karen, soldatessa ventenne dell’IDF che, in merito al suo compito, ha dichiarato al settimanale israeliano Haaretz: “È molto allettante che sia io a farlo. Non tutti vogliono questo incarico. Non è una cosa da poco occuparsi di un joystick come quello di una Sony Playstation e uccidere, ma ultimamente viene fatto per difendersi”.
L’esercito, il pilastro dell’identità sionista israeliana
La società israeliana, composta per sua natura da un melting pot di differenti etnie ebraiche scampate clandestinamente alla shoah o immigrate in tempi più recenti da regioni dell’est europeo e africane, è pervasa da fenomeni culturali, politici, religiosi e mediatici che supportano il casus belli di ogni operazione militare e che giustificano la sproporzionata efferatezza della reazione, motivata da ragioni di tipo sia politico che storico e addirittura religioso.
Il vero significato dell’ebraismo trascende le identità tribali e si impegna per la giustizia sociale ed è per questo che Ebraismo nel mondo significa mille cose diverse. Ma il vero significato dell’ideologia sionista, e l’unico concetto di ebraismo espresso in Israele, significa oggi solo una cosa: fare soldi con le armi e con il sangue, uccidere per trasformare il sangue in denaro. L’esercito, il pilastro dell’identità sionista israeliana, leader nel mondo per la produzione, sperimentazione, assistenza, addestramento, trasporto e vendita di armamenti, impone come sistema educativo una poderosa macchina di indottrinamento per i propri militari.
L’esercito israeliano chiama sè stesso Israeli Defence Force (Forza di Difesa di Israele), ed è uno dei più armati e tecnologicamente avanzati al mondo, composto da circa 200.000 militari perlopiù di leva.
La chiamata alle armi avviene al compimento del diciottesimo anno di età, dura 36 mesi per gli uomini, 24 mesi per le donne e in caso di necessità può mobilitare circa 500.000 riservisti che continuano a prestare servizio per un mese all’anno fino al compimento del 42 esimo anno di età.
Il patriottismo, il coraggio, l’eroismo, la purezza delle armi che difendono il legittimo diritto alla propria Terra da parte del popolo ebraico israeliano, la “purezza delle armi”, stemma, orgoglio e gloria dell’esercito israeliano, quando tradiscono i propri elevati ideali compiendo crimini di guerra contro una popolazione civile palestinese vinta, umiliata e imprigionata, dimostrano il proprio punto debole e il proprio tallone d’Achille.
Quella dell’aumento di uso di sostanze stupefacenti da parte dei soldati, dell’aumento dei casi ufficiali/non ufficiali di suicidio e dell’aumento del numero di “refusnik” – obiettori di coscienza – arrestati, processati e incarcerati per essersi rifiutati di prestare servizio di leva o di essere richiamati come riservisti, è una realtà che tutti conoscono in Israele ma di cui non si può parlare.
Il coraggio di rifiutare di combattere
Le associazioni, i comitati di madri, i gruppi di donne israelo-palestinesi, gli stessi soldati o soldatesse impiegate in battaglia, non riescono a parlare liberamente senza essere accusate di tradimento, disfattismo e viltà. Breaking the Silence, Courage to Refuse, Gush Shalom, Taayush, New Profile, Target 21, B’Tselem, Peace Now, sono espressioni della società civile israeliana rivolte ai giovani -i cosiddetti “movimenti pacifisti radicali di sinistra israeliani”– che nonostante siano sempre state condannate per aver raccolto e divulgato testimonianze dirette sugli ordini impartiti durante il servizio di leva, non hanno mai smesso di andare alla radice del problema: la colonizzazione, l’occupazione e l’apartheid praticata da Israele nei confronti della popolazione palestinese.
Nel 1985, Yeshayahu Leibowitz, docente ebreo ortodosso presso l’Università Ebraica di Gerusalemme, rilasciò un’intervista al quotidiano Yedioth Ahronoth, in cui espresse sostegno ai riservisti dell’esercito che si rifiutavano di servire nella guerra di Israele in Libano. Il rifiuto iniziò da allora ad essere considerato una tattica politica legittima, necessaria e vincente nella realtà israeliana: “Il rifiuto di servire, anche se è la norma solo all’interno di una minoranza, potrebbe disinnescare il consenso nazifascista e diventare il primo passo sulla strada per uscire dalla barbarie”.
Nel gennaio 2002, al culmine della Seconda Intifada, un gruppo di 51 militari riservisti ha pubblicato la “Lettera dei Combattenti” nella quale dichiaravano il loro rifiuto di prestare servizio nei Territori Occupati. La presenza dell’esercito lì, hanno detto, non riguardava più la protezione di Israele, ma aveva invece lo scopo di “dominare, umiliare, affamare ed espropriare un’intera nazione”. Decine di altri militari hanno firmato la lettera e in poche settimane quasi un migliaio di soldati e numerosi ufficiali in carica o riservisti hanno espresso la volontà di unirsi in quello che, iniziato con poche parole su una pagina di Haaretz, si è trasformato in un dilagante movimento.
Leader politici e generali dell’esercito si sono precipitati a condannare la lettera. La Commissione per gli Affari Esteri e la Sicurezza della Knesset ha tenuto un lungo dibattito sull’iniziativa, in cui l’allora Capo di Stato Maggiore dell’esercito Shaul Mofaz ha accusato gli ufficiali che hanno firmato la lettera di ammutinamento. Erano paracadutisti, comandanti di carri armati, luogotenenti e capitani in servizio nelle unità sul campo, ufficiali di sottomarini e pattugliatori navali: molti di loro furono congedati dalle loro unità, centinaia hanno scontato pene detentive.
“Noi, ufficiali riservisti dell’esercito e soldati delle Forze di Difesa Israeliane, cresciuti secondo i principi del sionismo, del sacrificio di sé e alla fedeltà al popolo e allo Stato di Israele, che hanno sempre servito in prima linea, e che sono stati i primi a svolgere qualsiasi missione al fine di proteggere lo Stato di Israele e rafforzarlo. Noi, ufficiali dell’esercito e soldati che abbiamo servito lo Stato di Israele per lunghe settimane ogni anno, nonostante il caro costo per le nostre vite personali, siamo stati in servizio come riserve nei Territori Occupati e abbiamo ricevuto comandi e direttive che non avevano nulla a che fare con la sicurezza del nostro Paese, ma avevano l’unico scopo di perpetuare il nostro controllo sul popolo palestinese. […] Con la presente dichiariamo che non continueremo a combattere questa guerra degli Insediamenti. Non continueremo a combattere oltre i confini del 1967 per dominare, umiliare, affamare ed espropriare un intero popolo.”
[estratto della Lettera dei Combattenti, gennaio 2002].
Alcuni dei primi 51 membri del gruppo in seguito si sono riuniti nel movimento “Courage to Refuse”(Coraggio di Rifiutare) sostenendo molte altre lettere di rifiuto pervenute da componenti di unità d’élite, piloti dell’Aviazione, veterani della prestigiosa intelligence 8200, studenti pre-arruolamento e supportando dozzine di adolescenti israeliani condannati a lunghe pene detentive per aver rifiutato di prestare servizio militare a causa della loro opposizione all’occupazione. Tra loro molte donne e persone provenienti dalle minoranze etniche più povere e svantaggiate.
Breaking the Silence, una delle prime organizzazioni fondata nel 2004, ha pubblicato nel 2009 un libro di testimonianze controverse sulle tre settimane di invasione della Striscia di Gaza nel corso dell’operazione Piombo Fuso. “La nostra logica difficile: Testimonianze dei soldati israeliani dai territori occupati, 2000-2010”, raccoglie 145 interviste che hanno spinto il ministero degli Esteri di Israele a chiamare la Spagna, i Paesi Bassi e altri governi stranieri affinchè tagliassero i fondi per l’organizzazione.
Il silenzio sui militari suicidi
Nei primi anni Duemila sono apparse le prime informazioni relative ai suicidi nelle forze armate, pubblicate in forma anonima da un blogger conosciuto come “Eishton” (una combinazione di parole ebraiche per “uomo” e “quotidiano”), immediatamente divenuto oggetto di indagine da parte della Polizia Militare. Come prima cosa è stata rilevata una significativa disparità tra le statistiche di mortalità pubblicate dalle forze di sicurezza e il numero indicato nelle pagine del sito web ufficiale di commemorazione delle vittime di guerra, cosa che ha autorizzato a credere che il numero dei suicidi effettivi fosse molto più alto di quello indicato nelle statistiche ufficiali. La maggior parte di atti di suicidio nella popolazione sono commessi da individui clinicamente depressi; la maggior parte dei soldati che si suicidano sono persone da ritenersi fisicamente e mentalmente sane, ma che vivono una acuta crisi esistenziale senza speranza di uscirne.
Eishton ha chiesto (ma non ottenuto) che l’esercito obbligatoriamente rendesse noto il nome di ogni soldato caduto riportando la vera causa della morte: “Non sono solo i suicidi il problema, il problema è che vogliono farci pensare che ogni soldato caduto è morto al servizio del suo paese”.
Una delle campagne più efficaci proposte dalle organizzazioni pacifiste, ha proposto alla visione pubblica le foto personali dei soldati scattate nel corso del proprio servizio. Gli scambi di commenti relativi ai ricordi e la rilettura delle testimonianze in relazione ai fatti accaduti, ha consentito di avviare un percorso di presa di coscienza molto difficile da contrastare da parte del militarismo culturale e da parte della cultura della guerra.
ll sito israeliano “Israel Today” ha già da tempo segnalato il fatto che tra i soldati c’è un significativo aumento di richieste di trattamenti psicologici e un conseguente aumento dei casi di esonero da ulteriori impieghi sui campi di azione. Per le scene terribili alle quali hanno assistito o per i crimini che sono stati costretti ad eseguire come ordini loro impartiti durante ognuna delle precedenti operazioni nella Striscia di Gaza, centinaia di soldati israeliani hanno dovuto essere accolti e trattati in speciali ”reparti di psicoterapia”. Vien da chiedersi, inorridendo, cosa produrranno gli orrori di un genocidio come quello in corso nelle coscienze dei sopravvissuti.
Tra coloro costretti ad assumere il ruolo di esecutori materiali di crimini di guerra, c’è già chi sta tentando, in India o nella Striscia di Gaza, di rimuovere dal proprio interiore il trauma di un combattente al servizio di una lugubre polizia politica, anziché di un eroico esercito nazionale di legittima difesa.
Cover: Foto originale tratta dal docufilm “De Gaza” di Mirko Faienza e Franco Ferioli
Per leggere tutti gli articoli e gli interventi su Periscopio di Franco Ferioli, clicca sul nome dell’autore, oppure visita la sua rubrica Controcorrente








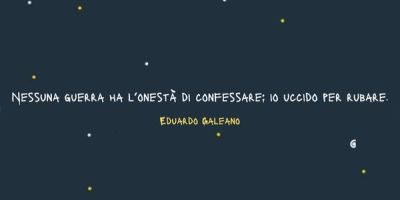
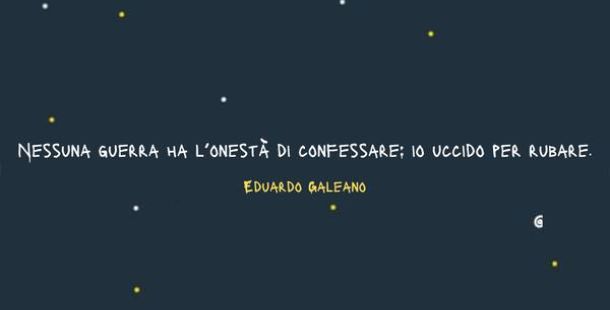








Molto interessante l’articolo sul disagio psicologico post traumatico di questi robot da guerra che sono i riservisti dell’IdF. Una verità poco conosciuta che merita di essere divulgata. Perché questa gentaglia fa Scuola. E presto potremmo assistere anche nella “civile” Europa l’addestramento di nuove leve di questo genere. Per sprofondare Ancor di più nella barbarie. C’è da aver paura.