Fantasmi /
Baher
Tempo di lettura: 6 minuti

l vecchio aprì la gabbia dei conigli e ne tirò fuori uno. L’animale tremava, e anche gli altri si addossavano alla parete in fondo, emettendo brevi grida stridule, presagendo di morire.
Lui sospirò – in fondo gli dispiaceva, ma doveva pur campare vendendo conigli e galline – e con un colpo secco alla testa uccise la bestiola. Poi attaccò il corpo al muro e cominciò a togliere la pelliccia.
“Allora, Fonso – disse Giacinto, che lo stava osservando in attesa di portar via il coniglio scuoiato – come state?”. “Mah – rispose il vecchio – cosa volete, sempre così, si tira avanti. Né male né bene. Solo gran fastidi dell’artrite. Sarà tutta l’acqua che ho preso a pascolare lassù in alto”. “E con i vostri animali, come la va?” aggiunse curioso Cinto. “Si campa e basta. Tiro su un po’ di più di quel che spendo: ghiribizzi non ne ho, basta il mangiare, la legna per scaldarmi, quel che serve per le bestie, un po’ d’attrezzi e i panni di ricambio che mi metto addosso” rispose Fonso. “Sono anziano e faccio con poco”.
Intanto il coniglio era già pronto per Cinto. “Prendete anche una dozzina di uova – gli disse Fonso – che sono fresche”. L’altro accettò l’offerta e pagò, poi i due bevvero un bicchiere di vino e si salutarono.
L’auto di Cinto, una vecchia Panda, sparì dal sentiero della collina. Fonso si asciugò il sudore – gli succedeva sempre di sudare, quando uccideva un coniglio o una gallina, col maiale poi non ne parliamo – e si sedette sulla panca davanti alla vecchia casa. Le nuvole correvano nel cielo, stava calando la sera. Le montagne erano giganti azzurri nell’aria viola. Le ombre stavano diventando lunghe, c’era una grande pace.
Era l’ora preferita da Fonso: quella in cui uno si sentiva più sé stesso, ma anche più solo. Sua moglie era morta anni prima, non avevano figli. Lui aveva risposto mille volte di no agli inviti del sindaco che voleva si ricoverasse nella casa di riposo per essere accudito. Si sentiva ancora in grado di badare a sé stesso e a vivere del poco che aveva: l’orto dietro casa, gli animali, una modesta pensione da cantoniere comunale. Quello che pesava davvero era la solitudine. Aveva pochi amici; uno di questi era il parroco, don Pietro, un poco più giovane di lui, con il quale aveva grandi discussioni, molto serene, e giocava tante partite a dama.
Fonso si riscosse, era ora di cena. Diede da mangiare ai conigli e chiuse le gabbie. Le galline erano già nel pollaio. Entrò in casa e si lavò le mani col sapone nel piccolo bagno che si era costruito qualche anno prima. Poi si sedette e tirò fuori un paio d’uova sode, la bottiglia del vino, un pezzetto di salame e una pagnotta. Mangiò lentamente nel silenzio, con gli occhi fissi alla finestra, dove il cielo diventava nero e si riempiva di stelle. Sulle colline si accesero molti puntini luminosi: erano le lucciole, amate compagne della sera. Dopo un po’ di tempo andò a coricarsi.
* * *
L’indomani Fonso scese in paese in auto a riscuotere la pensione e per qualche acquisto. Vide che nella piazza c’erano le giostre: era tempo di Carnevale. Si strinse nelle spalle: ricordò quando, da bambino, sua madre lo accompagnava a vedere le maschere e tornavano a casa con un pezzetto di torrone e qualche caramella. Ne mangiava una alla volta, adagio, per farle durare, il torrone lo assaporava a briciole.
Salutò qualche faccia nota e passò all’osteria per bere un bicchiere di vino e chiacchierare una mezz’ora. Entrò e si avvicinò al bancone. Mentre aspettava il vino, udì la conversazione di due paesani che raccontavano un fatto accaduto la sera precedente: sulla collina vicina a quella dove lui abitava, era stato notato qualcuno che si aggirava intorno ad una casa di contadini. Una donna che stava raccogliendo il bucato se ne era accorta e aveva gridato: la creatura era fuggita, sparendo nei boschi.
Tornò a casa facendosi molte domande. Chi si nascondeva sulle colline? Che cosa cercava? Era un uomo o una donna? Era già successo che degli estranei arrivassero improvvisamente nelle case lì intorno, ma si trattava di nomadi. Il pensiero dello sconosciuto – o della sconosciuta – lo accompagnò per alcuni giorni: certe sere gli pareva che lo spiasse, nascosto nella faggeta che sovrastava la sua casa.
Finché una notte, nel dormiveglia, sentì dei rumori che provenivano dalla legnaia. Si ricordò di aver lasciato il portone soltanto accostato. Si alzò, indossò il giaccone, afferrò la doppietta e la caricò, poi uscì all’aperto. Nel chiarore della luce lunare che inondava il cortile, vide una forma umana in piedi vicino alla legnaia. “Chi sei? vieni avanti con le mani in alto “ proferì ad alta voce. La forma uscì dal cono d’ombra e si rivelò: era un ragazzino, magrissimo e spaventato, che teneva le braccia sopra la testa. Fonso si avvicinò e vide che tremava violentemente. Abbassò il fucile e per qualche minuto i due stettero immobili a guardarsi. Poi il vecchio parlò. “Chi sei? Cosa cerchi?”. “Fame” rispose l’altro. “Fame. Io non mangiato. Tu mi dai pane?”.
Fonso non ci mise molto ad agire. “Vieni dentro” disse. E si avviò in casa, col ragazzo dietro. Entrarono in cucina e il vecchio mise sulla tavola pane, formaggio, vino e qualche fetta di prosciutto. Il ragazzino mangiò avidamente. “Piano, piano – disse Fonso – se no ti fa male. Piano”. Terminato il pasto, l’ospite inatteso guardò fisso Fonso, che gli domandò: “Come ti chiami? Da dove vieni”. “Io Baher, vengo da Afghanistan. Padre e madre morti, un fratello non so dove sta ora” rispose il ragazzo, che ricominciò a tremare. Indossava vestiti laceri, di stoffa leggera. “Senti – gli disse Fonso – adesso ti scaldo l’acqua e fai un bagno, dopo puoi dormire sul divano in cucina, vicino al fuoco. Domattina guardiamo cosa si può fare”. Aspettò che il ragazzo si lavasse, poi gli diede un pigiama di flanella, una coperta pesante e lo sistemò sul divano. Baher si addormentò quasi subito.
Fonso andò a letto, ma per un bel pezzo non chiuse occhio. Il sonno arrivò, pesante, verso la mattina. Quando si svegliò, il vecchio andò subito in cucina ma Baher non c’era più. Se n’era andato con i suoi vestiti laceri, indossando anche il pigiama. Con lui erano spariti pochi soldi che erano sulla credenza.
* * *
Passarono alcuni mesi e poco a poco Fonso dimenticò il ragazzo. All’istante c’era rimasto male, ma poi aveva pensato ai disgraziati che per fuggire dai posti dove erano nati attraversavano il mare e terre straniere, e che morivano annegati. Li vedeva nella vecchia televisione che accendeva qualche volta. Baher era solo al mondo e per sopravvivere aveva anche rubato. Ma non poteva essere cattivo, così giovane. Ecco – aveva pensato Fonso – bisogna distinguere i buoni dai cattivi, sempre. I buoni vanno aiutati, i cattivi no.
Un pomeriggio d’autunno, mentre spaccava della legna nel cortile, udì un rumore, come quello che fanno gli animali quando si muovono nel bosco. E se lo vide improvvisamente davanti. Era ancor più magro della volta precedente, malvestito e smunto.
Baher si avvicinò e s’inginocchiò davanti a Fonso. “Perdona se ho rubato… perdona” disse. E si mise a piangere, tremando. Il vecchio lo aiutò ad alzarsi: era leggero, leggero. Guardò il ragazzo in faccia, a lungo. Poi, con un sospiro, lo fece entrare in casa. Era ora di cena e mangiarono insieme. Poi Fonso disse, come l’altra volta: “Fai il bagno, e poi dormi sul divano. Ma stavolta non fuggirai, vero? Domani andremo da don Pietro per vedere se ti può tenere in canonica. Altrimenti puoi restare qui. Potrai andare a scuola e studiare, trovare un lavoro. Ti aiuterò. Vuoi?”. “Sì”, rispose Baher. “Io resto. Non scappo più”.
Racconto inedito, proprietà dell’autore
In copertina: Hussein, il bambino profugo che legge tra la spazzatura – immagine tratta da Avvenire.it : “Hussein legge. Legge nonostante tutto. Nonostante la guerra, la violenza, la sporcizia di questo mondo. E la sua immagine di piccolo rifugiato, così forte, in un cassonetto, con in mano un libro, ha saputo conquistare tutti. Hussein ha 10 anni è un profugo siriano e sta insegnando con pura inconsapevolezza la speranza e l’intimità, la compagnia e la forza che può offrire un libro in qualsiasi circostanza sotto qualsiasi latitudine.”.










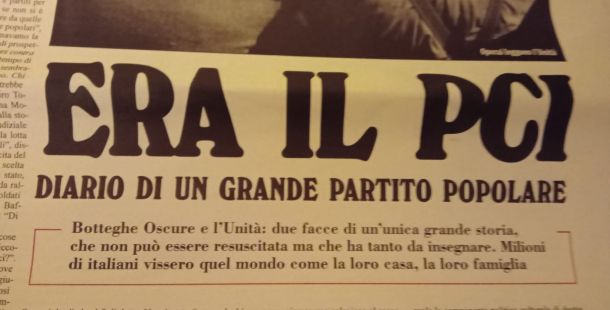







Davvero molto interessante e bello. Complimenti.
Bello! Davvero
grazie
f.s.