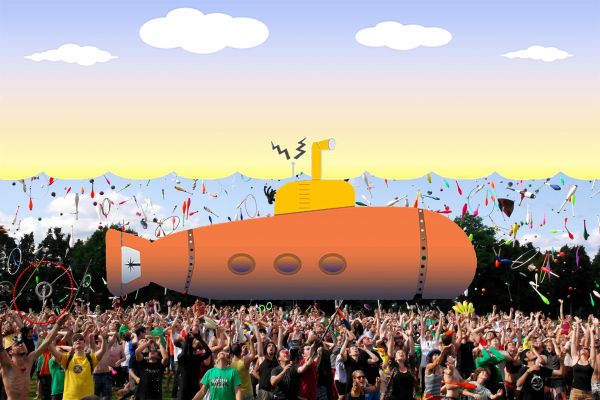«Katerina poverela Bologniese, cioè in Bolognia acquistata, nata e allevata. E in Ferara da Christo sposata»
(Deus et Christus meus [Dio che ti sei fatto mio Cristo], Monastero Corpus Domini, Ferrara 1980, 107).
Così in una lettera manoscritta dichiara di essere uscita verso Cristo e di aver scritto di sua mano il libriccino Le sette armi spirituali.
In un altro suo testo di vita interiore ispirato al Cantico dei cantici, nominato I dodici giardini, nell’introduzione scrive:
«Liberata dalla sottomissione a quelli, abbiamo da camminare nel deserto il cammino di tre giorni; questo lo troviamo nell’Esodo. E questa è quella deserta solitudine per la quale dobbiamo camminare per via di tre giorni.
Certo non è altrimenti possibile se non allontanati dalla conversazione mondana, percorrendo la via degli incipienti, proficienti e perfetti, pervenire a quella deserta e vasta solitudine, dove le anime nostre siano svuotate, spogliate e deserte e in tutto libere da ogni cosa terrena e cura mondana, e da ogni proprio sentimento della sensitiva carne. Tutto dobbiamo impegnare in questa sola occupazione… avendo lasciato ogni affetto alle cose inferiori tutte protese a quelle superiori…
(Con Cristo avremo) ogni altro diletto e non aspetteremo altro se non di giungere alla terra promessa; nella quale, sebbene i nemici che ci tenevano schiavi in idolatriche schiavitù, siano stati sommersi nel mare all’uscita dall’Egitto, tuttavia non potremo entrare senza dura lotta con molte genti.
Ma poiché all’amante niente è difficile (Cicerone. Or. X, 33), niente è gravoso, niente è pesante, con sicurezza e con il privilegio dell’amore sovrabbondante, prenderà il cammino di tre giorni come camminando per prati amenitosi e giardini» (ivi, 93; 95).
Mercoledì 9 marzo nella chiesa delle Clarisse del Corpus Domini in via Pergolato si festeggia solennemente santa Caterina Vegri [Qui].
VITA DI CATERINA VEGRI
Nasce a Bologna l’8 settembre 1413 da Giovanni de’ Vigri e da Benvenuta Mammolini. Nel 1424 entra alla corte Estense, come damigella di compagnia di Margherita d’Este, figlia naturale di Nicolò III. Riceve l’educazione culturale propria del tempo; impara anche la musica, la pittura e diventa esperta nell’arte della miniatura, della copiatura, nello scrivere in versi.
Nel 1427 lascia la corte Estense e si unisce a un gruppo di donne, che facevano vita comune, ispirandosi alla Regola di Sant’Agostino. In quel contesto spirituale Caterina maturò un orientamento vocazionale francescano scegliendo di intraprendere quella via di rinnovamento del proprio Ordine promosso da Bernardino da Siena [Qui], Giovanni da Capestrano [Qui] e altri frati, che predicarono anche nel monastero di Ferrara, a Santo Spirito e in città.
Da Bernardino ella prenderà la metafora delle armi spirituali del cavaliere di Cristo (miles Christi), come al suo tempo Francesco si fece cavaliere di Madonna Povertà. Così pure “Il sole radiante” che porta impresso le tre lettere del nome di Gesù, IHS – il trigramma bernardiniano che vediamo risplendere, al tramonto, in molteplici forme nel cotto sulle porte delle case ferraresi della zona medievale e pure dipinto nella volta della sacrestia di S. Maria in Vado sulla vela della barca della chiesa nascente − fu molto ammirato da Caterina.
L’amore per il nome di Gesù e per la sua umanità era anche testimoniata in città dai frati Gesuati[Qui] del Convento di san Girolamo e dal vescovo Giovanni Tavelli da Tossignano [Qui]. Nella facciata della Chiesa del Corpus Domini delle Clarisse il “sole radiante” è simboleggiato dalle specie eucaristiche, l’ostia e il calice, e non compare il trigramma del nome di Gesù che è implicito, silenziosamente, nel sacramento dell’eucaristia.
Così Caterina nel 1432 fa professione monastica con le altre compagne secondo la Regola di Chiara di Assisi [Qui] approvata da Papa Innocenzo IV. Solo 24 anni dopo lascerà per obbedienza Ferrara recandosi a Bologna, su insistente invito della cittadinanza e dei suoi maggiorenti, e in quella città resterà per sette anni, fino alla morte come Abbadessa del monastero felsineo.
L’ITINERARIO MISTICO DEI DODICI GIARDINI
Una delle sue immagini più note, quella di colei che intende intraprendere l’itinerario spirituale e mistico dei Dodici giardini, ciascuno dei quali porta il nome di un fiore, trovò forse ispirazione dal testo di un monaco cistercense medievale Guerrico d’Igny (1070-1157) [Qui] in cui si legge:
«Voi che percorrete i giardini delle Scritture, non dovete attraversarli in fretta e nemmeno con negligenza; scavate ogni parola per estrarne lo spirito; imitate l’ape diligente che estrae da ogni fiore il suo miele» (PL 185,211).
Come che sia, di giardino in giardino, attraversando questi luoghi di progressione spirituale, come dei gradini che ascendono − non dissimili dalle dimore del Castello interiore di Teresa d’Avila − Caterina percorre le tappe del suo esodo al femminile per arrivare alla terra promessa, al giardino segreto:
«E tu come ape piccolina non cesserai volitando di cercare dove tu possa suggere il gusto del mellifluo sapore per il quale non sarai lenta a cercare in te, se hai in te cosa che dispiace all’ amato Sposo» (ivi, 129).
Il dodicesimo giardino non è più nominato con un fiore, ma porta la dicitura: la sposa e lo sposo: «Ordunque che ti resta se non che tutta ti sommerga in quella ineffabile dolcezza. O della divina carità, la quale nel tuo dodicesimo e ultimo giardino distillerà in te della divina dolcezza.
Nel dodicesimo e ultimo giardino (la divina carità) da sé distillerà in te dolcezza di inestimabile e incomprensibile, inenarrabile carità divina, nella quale tu tanto ebbra, tanto congiunta, tanto assorta e tanto sommersa e inabissata, sarai dimentica di ogni tuo sentire e non sentirai pena, non tormento, non cosa tanto ardua e dura, che ti possa (anche solo) di un minimo distogliere da quella supereminente fruizione di tanta soavità e diletto, dicendo con il nobile trionfatore Paolo: “Chi mi separerà dalla carità di Dio; tribolazione o angustia, fame, o persecuzione, o spada?” (cfr. Rm 8, 35).
Dunque in questa fortezza di dilezione, gustando e dilettando te nella dolcezza di questa amorosa vite, canterai ebbra di quel vin, torchiato sopra il tuo cuore: “Mi ha introdotto nella cella vinaria e mi ha sommersa di carità” (cfr. Ct 2, 4), nella quale cella tu, per la stanchezza del lungo pellegrinaggio pigliando il tuo riposo, ti addormenterai nel grembo del Diletto, nel quale per intuito mentale sempre vedrai archana Dei per l’unificazione dell’amore che c’è fra te e Lui, con il quale già (sei) fatta una sola cosa.» (ivi, 147; 149).
La gioia, amorosa e mistica nell’unione, sperimentata da Caterina è tuttavia una gioia pugnace, combattente, in armi, che scaturisce dalla contemplazione della croce di Cristo e dalla partecipazione viva ai suoi misteri (un’altra sua opera si intitola proprio Rosarium, poema teologico in cui medita sui misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi della vita di Cristo). Tanto che anch’essa dovrà attraversare l’orto degli ulivi per giungere al giardino della risurrezione, il mattino di Pasqua.
LA DURA LOTTA DI CATERINA
La lotta di Caterina non risparmia colpi a ciò che non è in se stessa autenticamente umano. Un combattimento spirituale, intimo che ha lo scopo di arrivare a quel discernimento degli spiriti, a quella consapevolezza che fa passare da ciò che è inautentico, o ingannevole, alla verità e autenticità di sé, smascherando, nel profondo, ogni illusoria autoreferenzialità, sicurezza o falsa immaginazione: e così giungere al cuore del reale umano e cristiano, in grado al fine di distinguere la pagliuzza dalla trave, ben sapendo che un cieco che guida un altro farà cadere entrambi in un fosso.
L’affresco che orna il soffitto della chiesa del Corpus Domini è opera di Giuseppe Ghedini (1708-1791) e ricorda la visione avuta da Caterina in cui un angelo, «sonava una violeta e lo suono suo di quelle corde risonava queste parole: “Et gloria eius in te videbitur” = In te [Caterina] si vedrà la Sua gloria [di Dio], la sua luce.
È il buon combattimento della fede quello che si illumina nelle pagine delle sue armi spirituali per disarmare e disarcionare quei pensieri e parole capovolte, che scaturiscono da dentro l’uomo: «Dal di dentro infatti, − dice Gesù − cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive» (Mc 7, 21), mascherate da parole e pensieri retti, lupi travestiti da agnelli. Logismoi li chiamavano i Padri del deserto, pensieri che ingannano indicando false piste, sentieri che portano al nulla, fuori strada.
Questo duello interiore tra la Parola di Dio e le parole capovolte, tra i pensieri dissocianti e il pensiero di Cristo unificante, riemergendo ogni volta nella decisione della libertà chiamata a scegliere tra bene e male, creano quella tensione che nella vita spirituale si chiama tentazione. La tensione della coscienza posta ad un bivio della libertà, che deve scegliere la via che vivifica, rifuggendo da quella che mortifica la vita.
Maestra in questo duello fu Caterina per le novizie e le altre donne che si recavano al monastero: non per caso Specchio di illuminazione è il titolo del libro che narra la sua vita, scritto dalla beata Illuminata Bembo.
IL MESTIERE DELLE ARMI
Caterina si affida a sette armi per far fronte a quell’energia negativa, o a quella forza oscura e maligna che cerca per un verso di scimmiottare il divino e per l’altro di disorientare e disarticolare l’umano, di sviarlo, falsificarlo nel suo cammino, verso quel compimento dell’umanità di Dio rivelata nel Figlio amato.
Lui stesso nel deserto ha vinto per noi queste tentazioni, smascherando il diavolo/divisore, che gli si rivolgeva contro usando le stesse parole della Scrittura, al fine di farlo deviare e separarlo dalla sua missione di annuncio della prossimità di Dio, il Regno vicino.
La prima arma è la diligenza, cioè la sollecitudine nell’operare il bene. La seconda è il diffidare delle proprie forze. La terza è confidare in Dio. La quarta arma è il non dimenticare mai la gloriosissima incarnazione dell’immacolato agnello Cristo Gesù e la sua passione gloriosissima, rimedio di ogni nostra ferita! La quinta arma è il non dimenticare mai la nostra morte. La memoria delle beatitudini del Regno è la sesta arma; e l’ultima, quella per vincere ogni forma di inimicizia, è la memoria della Santa Scrittura, da portare sempre nel nostro cuore.
IL MESTIERE DELLE API
I Dodici giardini vanno letti alla luce del testo delle armi spirituali che indicano una via ascetica con intento didattico formativo per le sorelle; una via mistica che rivela la vita interiore di Caterina è invece quella che attraversa i giardini: l’itinerario del suo esodo amoroso al femminile.
Ella aveva appreso l’importanza simbolica del giardino presso gli Estensi, come forma della Corte e, memore di questo, lo impiega per descrivere la sua esperienza spirituale presso un’altra corte, quella del regno dei cieli.
Il primo giardino è chiamato issopo di umiltà; rose di contemplazione il secondo; fiori marini di purificazione poi; segue quello dei gigli di rinnovamento; viole di nascondimento il quinto, e a seguire garofani della conoscenza di sé. Nel settimo giardino incontriamo i girasoli di illuminazione o fiori di mezza estate; poi si entra in quello delle rose vermiglie di infiammazione. Oliva di unzione in misericordia è il nome del nono giardino e nel decimo incontriamo le arance di unitivo amore. Nel penultimo melograni di supernale (superiore) ansietà e, finalmente, nel dodicesimo avviene l’incontro della sposa con lo sposo.
Per le sue doti musicali bene si addice a Caterina Vegri l’antifona del breviario romano nella festa della vergine e martire Cecilia [Qui]: «Quasi apis ‘argumentosa’ Domino deservisti”: hai fedelmente servito il Signore come ape che rende “luminose le cose” e nell’operosità zelante hai fatto risplendere il loro significato».
Riporto pure qui un testo di Virgilio che avevo ricordato in uno scritto per il mio parroco Piero Tollini, che si era fatto apicultore e, utilizzando i proventi di quel mestiere, costruì l’altra metà della chiesa di Montalbano, la sua prima parrocchia:
«Nessuna passione innata di possedere incalza le api cecròpie, ognuna al suo posto di lavoro. Le anziane badano alle dimore, a munire i favi e plasmare i tetti con arte; ma sfiancate tornano a notte fonda le più giovani, le zampe colme di timo; colgono dovunque il cibo, sui corbezzoli e i salici grigi, la cassia, lo zafferano rossastro, il tiglio unto e i giacinti oscuri.
Per tutte uno solo è il riposo, una sola la fatica: al mattino si riversano dalle porte; non c’è sosta; di nuovo, quando la sera ordina di abbandonare finalmente il pascolo nei campi, allora si avviano a casa, allora si rifocillano; si leva un ronzio, rumoreggiano intorno alle entrate e sulle soglie. Poi, quando ormai si sono adagiate nelle stanze da letto, c’è silenzio per tutta la notte e il giusto sonno si impossessa delle membra stanche»
(Georgiche, IV, 175).
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]