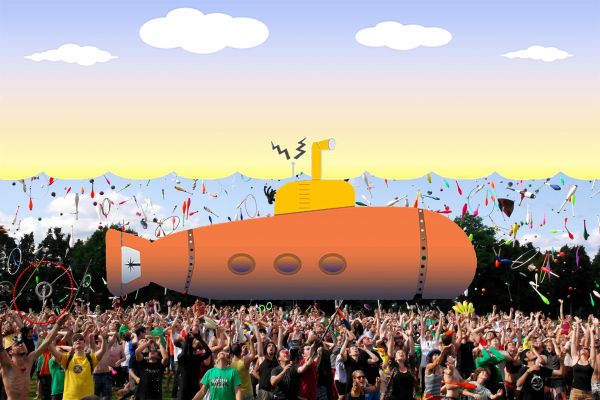DUE TESORI
Fuga verso Oriente
A volte capita di scoprire un tesoro. Per un colpo di fortuna o per un’improvvisa intuizione. Può anche essere un oggetto che rappresenta un ricordo significativo o un banale oggetto che, con il tempo, diventa sempre più importante per chi lo possiede. E questo accade quando quello che si è scoperto lascia un segno profondo nell’animo.
A me è capitato casualmente di trovare due tesori. Si tratta di due libri di viaggio, preziosi anche solo per le introduzioni scritte da due grandi viaggiatori: Tiziano Terzani e Paolo Rumiz.
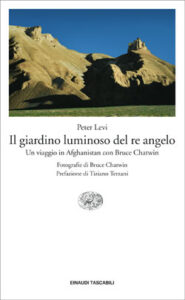 Durante la prima fase della pandemia, costretta come tanti dalle limitazioni e dall’isolamento a reprimere un profondo desiderio di viaggiare, avevo preso in prestito nella Biblioteca Cornelia di Roma un libro di Einaudi, oggi introvabile nelle librerie: Il giardino luminoso del re angelo di Peter Levi. Ne avevo intuito il valore potenziale e l’aura di mistero, anche grazie al sottotitolo Un viaggio in Afghanistan con Bruce Chatwin, con la prefazione di Terzani. L’autore, Peter Levi, un giovane gesuita di origine ebraica nonché poeta, con il bagaglio di una cultura smisurata, alla fine degli anni ’60 decide di intraprendere un viaggio in Afghanistan con il suo amico Chatwin. Li lega la passione per l’archeologia e la capacità di entrare “nell’anima dei posti, dei popoli, delle culture altrui”.
Durante la prima fase della pandemia, costretta come tanti dalle limitazioni e dall’isolamento a reprimere un profondo desiderio di viaggiare, avevo preso in prestito nella Biblioteca Cornelia di Roma un libro di Einaudi, oggi introvabile nelle librerie: Il giardino luminoso del re angelo di Peter Levi. Ne avevo intuito il valore potenziale e l’aura di mistero, anche grazie al sottotitolo Un viaggio in Afghanistan con Bruce Chatwin, con la prefazione di Terzani. L’autore, Peter Levi, un giovane gesuita di origine ebraica nonché poeta, con il bagaglio di una cultura smisurata, alla fine degli anni ’60 decide di intraprendere un viaggio in Afghanistan con il suo amico Chatwin. Li lega la passione per l’archeologia e la capacità di entrare “nell’anima dei posti, dei popoli, delle culture altrui”.
Un progetto simile non poteva accettare i limiti temporali e organizzativi fissati da un’agenzia di viaggio. Bisognava essere disposti a sopportare la fame, la sete, il caldo, il freddo, le intemperie, gli imprevisti, le complicazioni burocratiche e a farsi massacrare dalle zanzare, dalle cimici e dalle pulci. Gli ‘hotel’, presenti più che altro nei centri di una certa importanza, erano stati concepiti per commercianti e l’apertura al turismo era solo un’ipotesi.
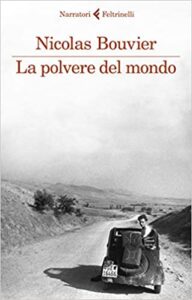 Un turismo ancora più ipotetico è quello raccontato dall’altro illuminante libro di uno svizzero di lingua francese, Nicolas Bouvier: La polvere del mondo, edito da Feltrinelli, con la prefazione di Paolo Rumiz. Bouvier nei primi anni ’50 decide di partire dalla Svizzera con un suo amico, pittore e fisarmonicista, a bordo di una Fiat Topolino e di attraversare i Balcani, la Grecia, la Turchia, l’Iran, l’Afghanistan, il Pakistan fino in India. Cercando, per mantenersi, di vendere quadri dipinti sul posto, articoli per giornali e riviste o tenendo conferenze. Anche in questo caso bisognava essere disposti a sacrifici fisici, ma principalmente essere pronti a capire che “la virtù di un viaggio è di purgare la vita prima di riempirla” e che bisogna privarsi “di ogni lusso eccetto il più prezioso: la lentezza”.
Un turismo ancora più ipotetico è quello raccontato dall’altro illuminante libro di uno svizzero di lingua francese, Nicolas Bouvier: La polvere del mondo, edito da Feltrinelli, con la prefazione di Paolo Rumiz. Bouvier nei primi anni ’50 decide di partire dalla Svizzera con un suo amico, pittore e fisarmonicista, a bordo di una Fiat Topolino e di attraversare i Balcani, la Grecia, la Turchia, l’Iran, l’Afghanistan, il Pakistan fino in India. Cercando, per mantenersi, di vendere quadri dipinti sul posto, articoli per giornali e riviste o tenendo conferenze. Anche in questo caso bisognava essere disposti a sacrifici fisici, ma principalmente essere pronti a capire che “la virtù di un viaggio è di purgare la vita prima di riempirla” e che bisogna privarsi “di ogni lusso eccetto il più prezioso: la lentezza”.
E così Bouvier e il suo amico Thierry Vernet, per svernare, decidono di concedersi lunghe soste anche di mesi, come a Belgrado e a Tabriz, in Iran, per poi affrontare il resto del viaggio in condizioni migliori. O per far riparare l’auto da meccanici tanto improvvisati quanto geniali, capaci di smontare camion per creare pezzi di ricambio da vecchie lamiere o altri arnesi di metallo, in mancanza di autentici ricambi occidentali, impossibili da trovare. Perché quello che manca, o almeno mancava in quei luoghi, era la tecnologia occidentale: quella gente non aveva “ occhi che per i motori, i rubinetti, gli altoparlanti e le comodità”. Invece Bouvier e il suo amico volevano “uscire dal vicolo cieco” della troppa tecnologia, “da quella sensibilità saturata dall’Informazione, da quella Cultura distratta, ‘di seconda mano’. Noi contiamo sulle loro ricette per rivivere, loro sulle nostre per vivere.” Difficile non pensare, oggi, al numero crescente di migranti ridotti alla fame ma disposti anche a morire, attratti da possibili, migliori condizioni di vita che l’occidente tecnologico potrebbe offrire loro.
Le strade. Negli anni ’50 in quei paesi non c’erano strade come noi oggi le conosciamo, ma piuttosto piste, carreggiate, percorse per millenni da popoli antichi, nomadi, pastori, conquistatori, invasori o commercianti e, all’epoca, percorse da rari camion variopinti che, a volte, incrociando una piccola auto in panne, spinta da due giovani, la salutavano col clacson e si fermavano per offrire mele, sigarette o nocciole e fare due chiacchiere. Come prevedere la durata del viaggio in paesi dove non esisteva la concezione occidentale del tempo e delle distanze… In quelle strade ciò che era degno di importanza, e dunque di segnalazione, era il passaggio alla ‘civiltà,’ – un ‘hic sunt leones’ al contrario – e allora ecco apparire un cartello con su scritto “Qui strada asfaltata”, prima di entrare a Quetta, in Afghanistan.
Quetta, “città sparsa, leggera come un sogno, piena di pause, di imponderabili cianfrusaglie e di frutti acquosi”. Città dove si potevano trovare “negozi dalle dimensioni di un armadio che vendevano zucchero di canna, sapone, una manciata di albicocche posate sopra della carta stagnola, oroscopi e piccoli sigari”.
E chissà se nel bazar di Herat c’è ancora una bottega con dentro “un polveroso dromedario con i paraocchi che fa girare un grande frantoio da olio pieno di semi di sesamo” (Levi). O se esistono ancora dei vecchi cantori ciechi che salmodiano il Corano guidati da ragazzi…
Solo con un lungo viaggio si poteva riuscire ad entrare nel fascino e nel mistero, oltre che dei luoghi, anche del caleidoscopio delle persone: abitanti di luoghi prescelti da molte civiltà, che si sono incontrate e si sono combattute, per poi inevitabilmente fondersi.
Non è un caso che persone come Alessandro Magno, Marco Polo, Robert Byron, Bruce Chatwin e Tiziano Terzani, tanto per citarne alcuni più o meno famosi, hanno deciso di percorrere questi luoghi, che affondano le loro radici nella storia dell’umanità. Da qui la presenza di numerosi siti archeologici e di antichi monumenti achemenidi e sassanidi, resti dell’arte timuride e safavide, siti Kushana, nonché greci.
Una delle ragioni che ha spinto Levi a visitare l’Afghanistan, l’antica Battriana, è stata la ricerca delle tracce della civiltà greca nel nord del paese, lasciate dall’esercito di Alessandro Magno nella conquista dell’impero Persiano e di nuove terre. Alessandro si era spinto sempre più a oriente fino nella valle dell’Indo, considerata allora l’ultimo confine del mondo. Numerosi siti conservano i segni architettonici e linguistici lasciati dai macedoni, poi ripresi da altre civiltà e altre culture.
Alessandro Magno aveva costruito in pochi anni il più grande impero mai apparso nella storia dell’umanità e aveva voluto che fosse patria cosmopolita di tutte le genti del mondo. Come Balkh, città importante prima di Alessandro e della civiltà persiana, non avamposto militare, ma ricca città mercantile, “luogo di incontro unico per popoli e culture”. La città venne poi rasa completamente al suolo da Gengis Khan nel 1220 e i suoi abitanti massacrati. Alessandro conquistò anche Herat, Kandahar e Ghazni, “città islamiche con resti buddhisti di epoca kushana su vestigia greche e probabilmente anteriori. Tutti questi luoghi avevano ospitato colonie ebraiche almeno nell’alto medioevo”.
Levi si sofferma anche nel Wachan, regione all’estremo nord est del paese, corridoio di terra attraversato da antichissime piste commerciali che si protende verso la Cina. Questa striscia di terra, con montagne e valichi altissimi, sotto la catena del Pamir, fu creata alla fine del XIX secolo dagli inglesi per proteggere il loro impero da possibili mire russe verso l’India. Probabilmente non pochi soldati macedoni decisero di restare lì, come nel Nuristan e in altre regioni dell’Afghanistan, e di fondersi con la popolazione locale. A volte è capitato a Levi e Chatwin di incontrare bambini con occhi azzurri e capelli biondi, possibili tracce di questo antico incontro tra popoli così lontani.
Purtroppo diversi decenni di occupazioni e guerre e la devastazione pressoché sistematica dei musei e dei siti archeologici da parte del radicalismo islamico hanno lasciato un segno indelebile. Noi, lettori contemporanei, dobbiamo accontentarci di rivivere il fascino e la magia di queste civiltà attraverso le immagini e il racconto di libri preziosi come questi. Non c’è internet, TV, social o altro che possano competere con la bellezza e la profondità che ci può riservare la lettura. Devo ringraziare, per questo, la Biblioteca Cornelia di Roma per avermi offerto il dono della lettura del libro di Levi.
In copertina: Enrica Prosperi, tecnica mista, Petra