Cancel Culture: Statue che muoiono, Amazzoni che risorgono.
Tempo di lettura: 12 minuti
Prima di diffondersi come la forma di ribellione prediletta dai contestatori del passato razzista e colonialista occidentale ed essere etichettata come Cancel Culture, l’abbattimento e la deposizione delle statue ha interessato e ispirato sceneggiature e grandi opere cinematografiche.
Nel 1928 il regista Sergei Eisenstein fa cominciare Ottobre, il film capolavoro sulla Rivoluzione russa, con le immagini di una folla lillipuziana di proletari, soldati e contadini che a Pietroburgo abbattono una colossale statua dello zar Alessandro III. [Vedi qui i 20 minuti iniziali del lungometraggio]
Nella sequenza di apertura de La dolce vita, 1960, di Federico Fellini, un elicottero che trasporta una grande statua dorata di Gesù Cristo a braccia aperte sorvola un quartiere in costruzione nella periferia di Roma. [La dolce vita: scena dell’elicottero]

Nella scena cult del film Good Bye Lenin! del 2003 di Wolfgang Becker, la protagonista femminile scende per la prima volta in strada a Berlino dopo la caduta del Muro e rimane esterrefatta nel vedere una grande statua di Lenin che viene trasportata via da un elicottero militare. [scena cult del film]
Una scena simile era già stata rappresentata in La doppia vita di Veronica, 1991, di Krzysztof Kieślowski, ispirata da un fatto della storia berlinese post-Muro, ovvero lo smantellamento all’allora Leninplatz della grande statua in pietra di Lenin, con la sua testa di 3,5 tonnellate, ridotta in 129 pezzi seppelliti in una cava di sabbia.
I riferimenti storici, le allegorie e i simbolismi espressi dalle statue in questi capolavori del cinema d’autore trovano un epilogo nel documentario Anche le statue muoiono, girato in Africa e in Francia tra il 1950 e il 1953 dai cineasti Chris Marker e Alain Resnais, che si apre con questa frase: «Quando gli uomini muoiono entrano nella storia. Quando le statue muoiono entrano nell’arte. Questa biologia della morte è ciò che chiamiamo cultura».
Commissionata dalla rivista letteraria Présence africaine e appoggiata da numerosi intellettuali francesi vicini al movimento della negritudine, dopo la sua prima proiezione al Festival di Cannes nel 1953 e malgrado si sia aggiudicata il premio Jean Vigo nel 1954, la pellicola è stata censurata dal Centre National de la Cinématographie fino al 1963.
La censura è un’evidente conseguenza del fatto che i due registi si palesarono nel pieno della crisi coloniale attraversata dalla Francia, che da lì a un decennio avrebbe assistito all’indipendenza delle terre occupate in Algeria, Marocco, Tunisia, Africa occidentale, Africa equatoriale e Madagascar, con un documentario antimperialista che mostra come l’Africa diviene un laboratorio in cui si costruisce l’immagine del buon selvaggio imposta dall’uomo bianco e come l’arte africana e gli antichi significati che le appartengono vengano distrutti e sopraffatti.
La morte delle statue, intese come sculture, maschere e opere d’arte plastica, è chiaramente connessa alla nascita della commercializzazione dell’arte africana per il piacere dei ricchi colonizzatori, i quali pretendono che le statue continuino a vivere e a valorizzarsi nelle bacheche delle collezioni museali, mentre Resnais e Marker affermano l’opposto, ovvero che dalle teche dei musei le statue ci guardano ma non ci riguardano, dato che la funzione rituale, il simbolismo e l’autonomia del linguaggio che tali forme veicolano perdono il loro senso in uno spazio, totalmente decontestualizzato ed esclusivamente estetico, che le azzera.
Visto e analizzato da questo punto di vista, l’emergente fenomeno definito “Rivisitazione dell’Arte Coloniale”, nato dalla Cancel Culture, adottato dal Politicamente Corretto e qualificato come processo di de-colonizzazione post-museale dal Governo Francese in primis nei confronti della Repubblica del Benin, appare come una precipitosa fuga attraverso l’uscita di emergenza della storia, giù per scala di sicurezza del proprio passato colonialista.
I sottili limiti esistenti da secoli fra saccheggio e collezionismo da un lato, e mercato e schiavismo dall’altro, continueranno ad essere di stretta attualità anche dopo il 2022, in quella che si è presentata come una inaugurale stagione africana di appuntamenti fortemente simbolici e chiaramente rivelatori del rapporto che l’arte intrattiene con gli splendori e gli orrori della storia coloniale e che ha salutato la Repubblica del Benin come primo Stato dell’Africa subsahariana a rientrare in possesso di una parte del proprio patrimonio culturale sottratto da una potenza coloniale europea e che ha visto la Repubblica Francese come primo Paese al mondo a restituire a un Paese africano colonizzato una simbolica parte maltolta del suo patrimonio.
Nel confronto tra primati e primatisti, a manifestarsi è però un deficit insanabile.
Le prime richieste di restituzione da parte dei Paesi africani risalgono infatti agli anni Sessanta e per sessant’anni i Paesi europei hanno reagito senza compiere un solo passo in avanti. Parlare di restituzione è stato una sorta di tabù o di muro abbattuto solamente negli ultimi anni da cause legali mosse da comitati, associazioni, intellettuali e capi di Stato: dal 2019, oltre al Benin, anche Senegal, Costa d’Avorio, Nigeria, Zaire, Etiopia, Ciad, Mali e Madagascar hanno inoltrato richieste ufficiali.
L’insensibilità con la quale il colonialismo europeo ha impedito il senso contestuale/culturale dell’arte africana, l’assenza di dialogo culturale con i popoli indigeni, lo sviluppo di un’arte di mercato dove il bianco è l’intenditore-compratore di manufatti da inglobare nel sistema estetico e formale dell’arte occidentale, toccano i punti cruciali delle riflessioni sul valore storico-antropologico che i manufatti artistici possiedono per le società che li producono.
Tutti sanno come le popolazioni indigene siano state pagate per vendere la loro stessa identità e il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, tutti sanno che l’arte nera è stata il più delle volte rubata, come ha testimoniato in molte pagine del suo diario di viaggio, L’Africa fantasma (1934), l’etnologo Michel Leiris negli anni della Missione etnografica Dakar-Gibuti (1931-1933) che arricchì a dismisura i depositi del Musée de l’Homme di Parigi con 3.600 oggetti, 300 amuleti, collezioni di pitture, manoscritti in 30 differenti lingue, 6.000 fotografie…
Leiris ha denunciato i mezzi spicci e predatori con cui gli etnologi francesi si sono appropriati degli oggetti artistici o rituali degli indigeni e con cui estorsero informazioni su celebrazioni, tradizioni, canti e danze riservate agli iniziati e nel libro egli si rimprovera di aver usato esattamente gli stessi metodi dei colleghi: il furto e l’inganno.
Per tutti questi motivi, l’uscita del libro, nel 1934, venne accolta con aperta ostilità: il capo missione Marcel Griaule -assistente all Ecole des Hautes Etudes, etnografo e linguista- furioso, definì l’ex amico, “un uomo senza onore che ha compromesso l’avvenire degli studi sul campo”; Marcel Mauss- luminare dell’antropologia culturale francese- ridusse Leiris a un “letterato” e “non un etnologo serio”; il Ministero dell’educazione nazionale stigmatizzò il libro come “opera la cui apparente intelligenza è dovuta soltanto a una grandissima bassezza di sentimenti”. Gran parte delle copie andarono al macero: la distruzione totale verrà completata sette anni dopo, nel 1941, ormai sotto l’occupazione tedesca, quando il Ministero degli interni del governo di Vichy interdisse ufficialmente l’Afrique Fantome. Solo nel 1951, il volume sarà finalmente ristampato venendo riconosciuto da molti, insieme a Cuore di tenebra di Joseph Conrad, come uno dei capolavori letterari che l’Africa ha ispirato.
Il significato dell’arte “primitiva” è stato alterato e gli indigeni pagati per vendere il loro patrimonio culturale e la loro stessa identità, trasformando le loro vite in una farsa diretta dai colonizzatori, in cui la sfera magico-religiosa viene rimpiazzata dagli interessi economici speculativi dell’Occidente e pervasa da un concetto di “esotismo esteriore” che coglie motivi ornamentali e periferici in grado di suscitare un “interesse autoreferenziale e uno spaesamento temporaneo circoscritto e fine a sé stesso”, come lo ebbe a definire Elemire Zolla in Uscite dal Mondo, (1992, capitolo: Parigi fra il 1862 e il 1932).
Resnais e Marker, difendendo il diritto di riconoscimento dell’arte africana in tutte le sue sfaccettature e livelli di complessità storica, sociale, artistica, rituale, magica, estetica e performativa, si domandarono: «Perché l’arte nera si trova esposta al Musée de l’Homme, mentre l’arte greca o egiziana sono esposte al Louvre?». Un interrogativo lapidario che ancora oggi pone non pochi problemi alla ricerca e alla critica antropologica, artistica e museale.
Interrogativo che pone problemi anche all’atteggiamento patriarcale colonialista che preferisce parlare di “museo dell’uomo”, di “uomo preistorico”, di “evoluzione dell’uomo” piuttosto che di umanità. Con il loro quesito, i due autori hanno avviato l’urgenza di un processo di de-mistificazione e di de-musealizzazione dell’arte indigena, problematizzando il tema del presunto primitivismo africano e sostenendo che quando vengono sottratte, inventariate, comprate a basso prezzo, rivendute ai proprietari dei negozi di antiquariato, ri-collocate ed esposte dietro le vetrine museali, “anche le statue muoiono”. L’affermazione dei due registi mette in discussione lo statuto dell’istituzione museale, sostenendo che un oggetto è morto quando lo sguardo attivo, vivente, antropologico, che si posa su di esso, è annullato. Per l’arte africana ciò avverrebbe quando i manufatti vengono inseriti nei circuiti museali dove muoiono formando, più che una collezione, un cimitero.
E’ in merito a tali considerazioni che si è parlato di rinascita espositiva -oltre che di crollo di un muro- a proposito del grande successo ottenuto, con centinaia di migliaia di visitatori dal 21 febbraio al 22 maggio, e grazie alla riapertura dal 16 luglio al 15 settembre, dalla mostra “Arte del Benin di ieri e di oggi: dalla restituzione alla rivelazione” presso le sale provvisorie del palazzo Presidenziale della Marina di Cotonou.
La seconda parte di questa esposizione, chiamata “Tesori Reali del Benin” ha presentato ventisei opere restituite dopo centotrenta anni trascorsi nei musei francesi, da quando cioè, nel 1892, la Francia attaccò il Regno del Dahomey con il pretesto di condurre la lotta al cannibalismo, ai sacrifici umani e alla poligamia attribuite alle popolazioni autoctone, mentre in realtà stava procedendo per completare l’occupazione di quella che sarebbe divenuta l’Africa Equatoriale Francese, una federazione di possedimenti di 2.349.651 km² che si estendeva dal fiume Congo fino al deserto del Sahara.
All’epoca non esisteva una legge internazionale sul saccheggio delle opere d’arte, gli ufficiali francesi poterono agire liberamente a titolo personale e non si saprà mai con esattezza quanti oggetti preziosi siano stati prelevati e quanti altri senza dubbio siano ancora oggi nelle mani dei loro discendenti. Secondo stime accertabili in Francia si troverebbero 90.000 manufatti artistici di inestimabile valore, dei quali 46.000 -meno 26- sottratti durante il periodo coloniale.
Fu il colonnello franco-senegalese Alfred Amédée Dodds, tra il 1893 e il 1895, a restituire al Museo Etnografico del Trocadéro i ventisei tesori reali sequestrati nella reggia di Abomey che sono stati esposti nella capitale beninese, tra i quali spiccano il trono di Re Béhanzin, quattro porte del palazzo del re Glélé, tre statue reali antropomorfe metà uomo-metà pesce di Béhanzin, metà uomo metà leone del re Glélé e metà uomo metà uccello del re Ghézo, attribuite al grande intagliatore Likohin Kankanhau Sossa Dede, oltre a scettri, monete d’oro, gioielli in avorio e metalli preziosi, sculture sacre, arredi, tessuti e oggetti di uso rituale e quotidiano.
Dodds ha inoltre contribuito a svelare il mito relativo al leggendario corpo di élite dell’esercito imperiale del Regno del Dahomey, noto per le popolazioni Fon, Yoruba, Ewè e Ashanti con il nome di N’Nonmiton, Mino o di Agodjies, che venne poi descritto dai colonizzatori francesi e inglesi con il nome di Amazzoni del Dahomey.
Quando partì da Cotonou alla testa di oltre tremila uomini, dal 26 ottobre al 17 novembre 1892, prima di conquistare e saccheggiare la capitale Abomey, dovette affrontare la resistenza all’ultimo sangue di un esercito composto da sole donne guerriere giudicate superiori ai soldati maschi in termini di fedeltà, coraggio e valore in battaglia.
L’esercito maschile e le popolazioni locali si difesero strenuamente e si contarono ben ventitrè cruenti battaglie e massacri alle quali presero parte i combattenti della Legione Straniera armati di micidiali mitragliatrici. Quella del 26 ottobre fu la battaglia più sanguinosa. A cinquanta chilometri da Abomey, i francesi dovettero affrontare un esercito immenso, composto da donne, intervenute per tentare di opporre un’ultima strenua resistenza.
Dimostrarono di non aver nessuna paura né di uccidere, né di morire.
Si lanciarono all’attacco in prima linea e combatterono senza nessuna remissione, usando la tecnica di combattimento da loro preferita, il corpo a corpo.
Mentre i francesi tentavano di mantenerle a distanza a mitragliate, le donne cercavano lo scontro fisico diretto e si catapultavano davanti alle baionette dei soldati per affrontarli faccia a faccia.
I soldati francesi rimasero sorpresi dal loro coraggio e atterriti dal fatto che non esitavano a decapitare i nemici uccisi, per ritornare all’attacco impugnando le loro teste. Nonostante la loro eroica resistenza, le N’Nonmiton non riuscirono a tenere testa alla superiorità militare dell’esercito francese, ma non si arresero e vennero sterminate: il 17 novembre 1892, quando i francesi raggiunsero la capitale Abomey e dopo gli ultimi attacchi venne istituito il Protettorato Francese, ne sopravvissero soltanto un centinaio.
Gli aspetti leggendari legati alle Amazzoni del Dahomey presentati per la prima volta in Europa dai Francesi tramite le imprese di Dodds negli ultimi decenni dell’Ottocento, sono strumentali e viziati da una visione patriarcale finalizzata più a riflettere l’impegno dei soldati francesi e i presupposti ideologici di conquista coloniale con i quali venivano impiegati in Africa, che non a considerare che la tradizione locale legata a queste donne era molto più antica, dal momento che le origini delle Mino sono attribuibili a una principessa della famiglia reale di Tado, di nome Abigbonu, che avrebbe generato le dinastie sovrane di tutti i regni sorti tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo nelle regioni centromeridionali delle attuali repubbliche di Togo, Ghana e Benin, cioè in una culla della civiltà che si ritiene sia stata abitata senza interruzioni perlomeno dal 3.700 a.C.
L’esempio materiale di come avrebbe potuto nascere un esercito composto da donne guerriere fu però merito di un’altra principessa, Tasi Hangbè, figlia del re fondatore del regno di Dahomey, Aho Houegbadja e sorella gemella del quarto re Houessou Akaba, che durante una battaglia contro un popolo rivale, travestitasi da suo fratello gemello rimasto ucciso sul campo, impugnò le armi e si mise a combattere al comando dell’esercito senza essere riconosciuta dal nemico.
Tasi Hangbè, divenne regina, salì al trono subito dopo la morte del fratello e regnò dal 1708 al 1711 e il suo ricordo ha ispirato la recente costruzione di una gigantesca statua in bronzo di 30 metri di altezza, opera dell’artista cinese Li Xiangqun, che domina come un faro la capitale sul sito del Memoriale della Riconciliazione, dietro il Palazzo della Marina.
L’esploratore Richard Francis Burton ha lasciato dei commenti sulla mascolinità fisica di queste donne, che le rendeva in grado di competere con gli uomini in quanto a forza, resistenza e capacità di sopravvivenza alle privazioni, precisando che le dimensioni del loro scheletro e della loro massa muscolare erano tali che la femminilità poteva essere rilevabile solo dal seno.
Servire nel Mino offrì alle donne l’opportunità di essere rispettate ed equiparate agli uomini, di salire a posizioni di comando, di godere di influenza, prestigio e privilegi, come quello di avere diritto a propri schiavi e di assumere ruoli di rilievo nel Gran Consiglio discutendo la gestione del regno anche in materia di politica estera.
Stanley Alpern, autore dell’unico studio completo in lingua inglese intitolato Amazons of Black Sparta, ha scritto che quando le Amazzoni uscivano dal palazzo, erano precedute da una serva che portava una campana. Il suono imponeva a ogni maschio di allontanarsi dal proprio percorso, ritirarsi a una certa distanza e guardare dall’altra parte.
Intoccabili e giurate, non potevano sposarsi o avere figli ed erano soprannominate “Le mogli del re” perché facevano un voto di castità prima di entrare nell’esercito e proteggevano il trono finché non esaurivano il compito che era stato loro affidato fedeli al proprio motto “vincere o morire”.
La giornalista francese Marie Madeleine Prevandeau negli anni ’30 fu una delle prime europee a parlare di queste guerriere cercando di interpretare la loro esistenza e il loro esempio come prova di un movimento femminista ante litteram, rilanciando l’idea di una primitiva civiltà delle donne e di un passato matriarcale dell’umanità inteso non come semplice ribaltamento del patriarcato, cioè la dominazione opposta di un sesso sull’altro, ma di una cultura di bilanciamento dei ruoli.
L’adattabilità, lo spirito di sopravvivenza, la resistenza, la capacità di autogovernarsi, l’insofferenza per i ruoli imposti dalle differenze di genere, sono state le doti più importanti delle Mino, esempi di donne rivoluzionarie, anticolonialiste, intellettuali, che potrebbero essere utili e in grado di imprimere alla prospettiva storica del passato un esemplare parallelismo con il presente, rafforzato dalla scelta di veicolare l’identità visiva, l’immagine pubblica e il richiamo turistico della Repubblica del Benin tramite la statua-simbolo della bellezza, della forza e dell’emancipazione delle N’Nominton – Le nostre madri – le uniche donne combattenti in prima linea, conosciute e documentate nella storia delle guerre moderne.
In copertina: Repubblica del Benin, costruzione della colossale statua della Regina Tassi Hangbé












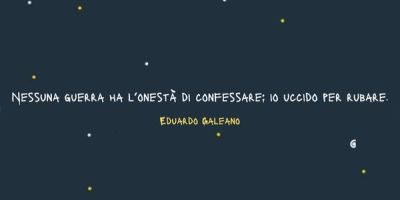









Grazie Franco, finalmente in primo piano la Storia d’Africa, quello che nella vulgata occidentale era “il Continente Nero”.