Diorama
Tempo di lettura: 5 minuti
Diorama
Il presepio lo conoscono tutti, è quello il diorama più noto, il diorama per antonomasia. Andate a Napoli, non nelle chiese ma nelle case private, anche nelle più povere, per vedere come il presepio – costruirlo pezzetto per pezzetto – non sia solo tradizione o passione intima, ma arte assoluta. Presepi e diorami in genere ci accompagnano da secoli; abbiamo bisogno di miniaturizzare il mondo, in scala ridotta ci pare meno complicato e doloroso. È un meccanismo che funziona alla perfezione e che possiamo dominare: le ruote girano, le luci si accendono e si spengono, i personaggi ripetono con diligenza i movimenti previsti. C’è poi altro che ci incanta davanti a un diorama costruito a regola d’arte, perché quel mondo in scala ridotta rimpicciolisce anche chi lo osserva; così la nostra infanzia ci raggiunge, senza preavviso, né possiamo opporci al suo ritorno. Anche questo, ma non è ancora tutto. C’è un elemento imponderabile, di cui ci sfuggono i connotati, che non riusciamo a vedere ma di cui avvertiamo la presenza. Da qui la fascinazione del diorama.
Se intendiamo il diorama come una categoria, alla stessa possono appartenere insiemi di oggetti e soggetti affatto diversi: il villaggio o la casa delle bambole, ma anche il drammatico compianto di Nicolò dell’Arca e, per estensione, i sassosi giardini zen. Nell’ultima decade del secolo scorso è stato il grande Hanshiro Miura a condurre il diorama fino al vertice della più apprezzata e discussa arte contemporanea, quella battuta nelle aste internazionali inseguendo record su record. Cha no yu – letteralmente “acqua calda per il tè” – nota in occidente come ‘La cerimonia del tè’ è senza dubbio la sua opera più celebre. Al centro della scena vediamo Sen no Rikyu, il monaco zen che nella seconda metà del XVI secolo codificò la cerimonia così come oggi la conosciamo. Attorno a lui, i suoi amici, i componenti del circolo eletto di Kyoto: il pittore e grande innovatore Tawaraya Sotatsu, il calligrafo e politore di spade Kon’ami Koetsu, il ceramista Chorijro creatore dello stile Raku e accanto a lui Futura Oribe, inventore e capostipite della ceramica che prese il suo nome. Un po’ più lontano, a formare un cerchio più ampio, stanno i samurai in pose plastiche, riccamente vestiti e armati. In questo diorama, il monaco Rikyu celebra il rito: il suo braccio regge la teiera e ne varia la posizione secondo le quattro stagioni. Una parvenza di fuoco arde sotto la teiera.
È però impossibile descrivere l’animata perfezione e gli innumerevoli particolari che compongono i diorami di Hanshiro Miura. Né può servire o comunque bastare rifarsi alla fonte di ispirazione di ogni singola opera: la tradizione e il rito (come appunto nella ‘La Cerimonia del tè’), o una celebre opera lirica (come nel diorama ‘Le sorelle di Turandot’), o la vasta filmografia del maestro Kurosawa (‘Appena dopo la battaglia’). I diorami di Miura sono inesauribili, non è cioè possibile traguardarli, comprenderli fino in fondo, riunirli nella memoria in una immagine esatta. La difficoltà non pare risiedere nel gran numero dei personaggi, delle situazioni e dei movimenti – l’esperienza del moderno ci ha abituato da tempo alla folla e al movimento – ma a un elemento di disturbo, a quell’invisibile presenza cui prima accennavo.
I diorami di Miura non sono solo belli, “i più belli di tutto il Giappone”. Non sono solo i più veritieri o verosimili, i più precisi, esatti in ogni proporzione, perfetti nei gesti e nei colori. In quel teatro portatile si affollano decine di figure immerse in una millimetrica ricostruzione degli ambienti e dei fondali, fino alla stupefacente e mutevole espressione incisa nei tratti dei volti. Ma oltre, o piuttosto, sotto questa perfezione, i diorami di Hanshiro Miura nascondono ed esibiscono senza pudore un’anima segreta. Non uso a caso la parola, è proprio l’epifania dell’anima a renderli straordinari, la ragione per la quale le mostre di Miura si trasformano puntualmente in un evento. È l’anima che attira come mosche decine di migliaia di visitatori.
Sotto il meticoloso, certosino, maniacale assemblaggio di oggetti inanimati – forse per una precisa intenzione dell’autore o per un puro prodigio – avvertiamo un’invisibile e inaspettata presenza. L’anima appunto, proprio quell’anima che dovrebbe essere – e solo per i pochi che si attardano ancora a crederci – una peculiare ed esclusiva proprietà dei viventi, non già degli oggetti e delle cose inanimate. Eppure, in ogni diorama del maestro Miura – ma forse, almeno un poco, in tutti i diorami e in tutti i presepi – si nasconde quella dimenticata entità. Mi sbaglio, l’anima dei diorami animati di Miura non è poi tanto nascosta. Dopo qualche minuto che li osservi, l’anima si mostra, salta fuori dal quadro, ti raggiunge, occupa il tuo campo visivo e la tua mente. Come un prigioniero che dal buio della materia rivede improvvisamente la luce. Né è possibile intendere da dove venga quell’anima, né dove si sia celata fino ad allora.
Così i visitatori curiosi, prima incantati davanti a quelle miniature perfette, dopo pochi minuti, eccoli turbati, quasi disturbati. Tornano verso casa muti, e quel disturbo li accompagna ancora per molti giorni. Guardate la faccia di questa coppia di mezz’età appena uscita dalla mostra, o i giovani volti di questo gruppetto di studenti. Sono facce spaventate.
Perché questa apparizione, questo svelamento, è un’esperienza che non si dimentica e che spaventa. Sempre, alla meraviglia davanti al “bello”, subentra un malessere cui non si riesce a dare un nome e una causa, ma che presto vince ogni resistenza. Non è infatti cosa di tutti giorni trovarsi faccia a faccia con l’anima, quella ambigua entità che, se i più consideravano pura invenzione, aveva comunque abbandonato da un paio di secoli l’umana esperienza del mondo.
I visitatori escono dalla grande sala, e per ore, per giorni, sembrano aver perso la favella, lo sguardo vuoto, i gesti svagati. Sognano molti sogni ogni notte ma al mattino evaporano come una nuvola e gli rimane solo il ricordo di un breve spavento.
Intanto, una lunghissima fila ordinata continua a sostare davanti alla biglietteria. La mostra del maestro miniaturista Hanshiro Miura è stata dapprima prorogata oltre il termine, quindi, a furor di popolo, è diventata un museo permanente. Chiunque voglia fare esperienza di quella cosa perduta, scomparsa dalla vita di ognuno, chiunque voglia incontrare l’anima, almeno per qualche attimo e almeno una volta nella vita, si mette in fila con gli altri. Con diligenza. Con molta pazienza. Ci sarà molto da aspettare, giorni, forse anni, ma alla fine arriverà il tuo turno
Per leggere tutti gli articoli e i racconti di Francesco Monini su Periscopio clicca sul nome dell’Autore











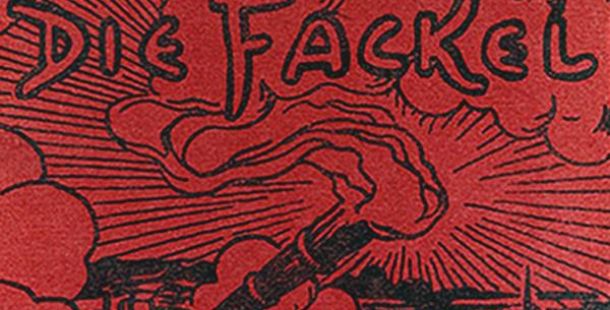




E’ molto bello e il Giappone è sempre pieno di sorprese!
Hai voglia a cercare l’autore di così tanta bellezza….
Sono caduta miseramente nell’incantesimo, come una mosca attratta dalla carta appiccicosa, alla ricerca del mistero dell’anima segreta che si cela al visitatore del diorama….
Rimango ad attendere il mio turno…
Centrale l’anima in questo racconto filosofico in cui il contesto fa da pretesto al suo svelamento. Come dice Platone la verità (a-letheia) rivela l’essenza (l’anima?) al centro delle cose, al di là delle cose. Leggo con molta serietà e nessuna ironia questo bel racconto di verità. Bravo Checco!